Devastazione sociale e devastazione ambientale sono due facce della stessa medaglia ovvero dello stesso modo di produzione.
tratto da “Etica e politica nell’Antropocene
(a partire dal contributo di Jason W. Moore)“; di Giulia Iacometti.
Parlando a proposito dell’appropriazione del lavoro Moore scrive: “Dovremmo assumere una fondamentale intuizione del marxismo femminista: il contributo del lavoro non retribuito non è un dato originario ma attivamente prodotto dai complessi rapporti di potere, (ri)produzione e accumulazione.”
In sostanza, secondo Moore, il “lavoro non retribuito” delle donne costituisce un contributo fondamentale e per nulla “naturale” alla riproduzione del sistema di potere capitalistico.
A conferma che questa è l’interpretazione da dare alle parole di Jason Moore leggiamo questo passo: “Alle origini del capitalismo, le strategie utilizzate per recintare le popolazioni indigene nelle riserve furono usate anche per creare e gestire una categoria di esseri umani che avrebbe dovuto svolgere lavori di cura non retribuiti: le donne.
I corpi umani furono costretti, a volte in
termini medici, sempre in termini giuridici, in una delle due ineludibili categorie: uomo e donna.
I risultanti dualismi società-natura, uomo-
donna e lavoro pagato-lavoro non retribuito ci hanno consegnato un modo di pensare che ha condotto gli esseri umani nell’ecologia-mondo capitalistica verso spettacolari cantonate: continuiamo a pensare come ‘vero lavoro’ unicamente il lavoro salariato e si dimentica il lavoro di cura che rende tutto possibile.”
Quella del riconoscimento (anche economico) del lavoro di cura svolto alle
donne è effettivamente una classica rivendicazione femminista.
Dal punto di vista politico però, più che il riconoscimento economico dello statuto
insuperabile di caregiver, le femministe marxiste hanno auspicato e operato per il superamento della tradizionale struttura familiare patriarcale e borghese che consegna alla donna il ruolo fisso di caregiver (senza tuttavia ritenere che il semplice arruolamento in fabbrica debba costituire, di per sé, chissà quale progresso).
Dal punto di vista teorico, Marx pensa il salario – ovvero la “retribuzione” – come valore (del costo di (ri)produzione) della merce forza-lavoro; anche quando le mogli non lavorano fuori, anche quando la famiglia ha una struttura del tipo “male breadwinner” – “female caregiver”, il salario deve permettere la riproduzione di tutta la famiglia (della donna che sta a casa, ma anche dei vecchi che non lavorano più, dei bambini che non lavorano ancora, dei disabili che non possono lavorare...).
Il salario non coincide mai con la sola busta paga – i marxisti lo sanno benissimo – e in ogni caso esso non potrebbe mai limitarsi a coprire la riproduzione del solo maschio che lavora perché quella riproduzione è una riproduzione sociale.
Si tratta dello stesso genere di incomprensione che conduce a non ritenere “salariato” il lavoro dello schiavo laddove, al contrario, lo schiavo deve essere nutrito, curato, vestito, alloggiato… sia pure in condizioni di estrema povertà (ma sufficienti da permettergli di lavorare produttivamente nei campi o in altre dure attività).
E, detto per inciso, mentre la morte dello schiavo era sempre una perdita secca di capitale – una sciagura per il padrone –, la
morte di un lavoratore è al massimo una seccatura, quella di trovare un altro “liberto” disposto a farsi sfruttare volontariamente.
L’impatto della logica di funzionamento del modo di produzione capitalistico
– accumulazione senza limiti di ricchezza e potere, appropriazione senza limiti di natura e tempo di vita umana – sulla “rete della vita”, come la chiama Jason Moore, è un tema di importanza fondamentale per il futuro, ma ormai, forse, anche per il presente.
Pur senza indulgere in atteggiamenti catastrofisti è chiaro che si delineano di fronte a noi emergenze rispetto alle quali ogni sottovalutazione si configura come un vero e proprio “crimine contro l’umanità” ed anzi contro la vita più in generale.
Il dibatto neo-ecosocialista in Italia è, oggi, pressoché inesistente.
Fatta salva la meritevole iniziativa di alcune riviste e di alcuni autori, i temi “ecologici” (compresi quelli ultralight del fu movimento Verde) sono stati completamente eliminati dal dibattito pubblico; questo non deve stupirci dal momento che parlare di vincoli ecologici significa parlare di vincoli economici e il capitale non ha alcuna intenzione di rispettare altri vincoli oltre quello del massimo profitto.
L’assenza di un dibattito italiano fa sì che spesso si sia costretti a riferirsi ad
elaborazioni che provengono dall’estero, specialmente dal mondo anglosassone.
Jason Moore, la Monthly Review ed altri animano un dibattito che pur nella sua importanza teorica e politica resta pur sempre un dibattito, a dir tanto, di nicchia.
Invece, le questioni ecologiche pongono un problema etico e politico fondamentale.
Anche volendo prescindere da impostazioni politiche di carattere radicale o marxista non possiamo non domandarci se sia giusto permettere lo sfruttamento indiscriminato dei lavoratori e il saccheggio indiscriminato della natura per consentire la riproduzione di un sistema capace di polarizzare la ricchezza al punto tale che 8 persone ne detengono tanta quanto 3 miliardi e mezzo.
E se rispondiamo che non è giusto e riconosciamo che lo sviluppo capitalistico sta conducendo il pianeta alla crisi sociale e ambientale, è giusto auspicare il ritorno ad un vagheggiato “piccolo mondo antico” oppure, al contrario, riconoscere che proprio nel futuro è collocata la soluzione degli enigmi che ci troviamo dinanzi?
E se diciamo futuro dobbiamo domandarci: quale futuro?
Un futuro capitalistico in cui tentare di mettere toppe tecnologiche necessariamente inadeguate ai problemi posti dall’uso capitalistico delle macchine e all’abuso capitalistico della natura umana ed extra-umana oppure un futuro nel quale la salvaguardia dell’uomo e della natura, e non l’accumulazione indefinita di profitto, siano collocati al centro della “rete della vita”?
Devastazione sociale e devastazione ambientale sono due facce della stessa
medaglia ovvero dello stesso modo di produzione.
In più occasioni Moore sottolinea il rapporto tra lavoro umano e lavoro extra-umano estendendo la riflessione di Marx sull’appropriazione di (tempo) di lavoro non pagato dal campo della società umana a quello dell’intero "oikeios".
Così come il capitalista si appropria di (tempo di) lavoro umano non pagato – il pluslavoro – allo stesso modo la società capitalistica si appropria di lavoro extra-umano non pagato (estraendo petrolio, tagliando alberi, incanalando acque…).
Il meccanismo, osserva Moore, è lo stesso; il profitto viene dall’appropriazione: “Un modo di vedere lo sfruttamento della forza-lavoro e l’appropriazione del lavoro non pagato svolto dalle nature umana ed extra-umana che formano un unico metabolismo di molte determinazioni”.
Di conseguenza, più si alza il costo dell’appropriazione della natura – Moore
parla di “fine della natura a buon mercato” – più si riduce la quota di profitto.
Marx, nel III libro del Capitale aveva osservato che la diminuzione del costo delle materie prime costituiva un elemento di contro-tendenza rispetto alla tendenziale caduta del saggio di profitto; evidentemente, all’opposto, maggiori costi delle materie implicano minore saggio di profitto.
L’accostamento tra i due concetti di “lavoro della natura umana” e “lavoro della natura extra-umana” proposto da Moore sembra orientato, diciamo così, ad “estendere Marx”; d’altra parte, pur essendo tale estensione suggestiva, essa può essere accolta solo a patto che qui il termine “lavoro” venga inteso genericamente come attività, dal momento che lo specifico lavoro dell’uomo è in realtà cosa piuttosto diversa dal generico lavorìo della natura la quale assai più difficilmente può essere pensato come “attività conforme allo scopo”, come finalità autocosciente.
Il tentativo di “estendere Marx” finisce per collocare Moore piuttosto lontano dalla riflessione marxiana proprio su un punto essenziale, ovvero sul concetto di lavoro.
Per fare un esempio, consideriamo il caso del petrolio: da una parte c’è il semplice liquido oleoso prodottosi nel corso di secoli grazie alla decomposizione di materiale organico di origine animale e vegetale (ma non per una qualche specifica finalità e meno che mai per la specifica finalità di soddisfare una qualche necessità umana); dall’altra parte c’è il prodotto estratto, trasportato, raffinato, distribuito ed usato come combustibile.
Il petrolio come combustibile non è un prodotto naturale, ma un prodotto sociale che si basa sulla trasformazione di uno naturale.
Questo non è un caso, bensì la regola: tutti i prodotti del lavoro umano sono sempre, in ultima analisi, trasformazioni di prodotti naturali di cui gli uomini si appropriano in un modo "storicamente e socialmente determinato".
La natura è il più originario di tutti i capitali, potremmo dire, parafrasando l’accumulazione “originaria” di cui Marx parla nel capitolo XXIV de Il Capitale.
“La terra è non solo la sua dispensa originaria, ma anche il suo arsenale originario di mezzi di lavoro”.
Ogni prodotto del lavoro umano è il punto d’arrivo di una catena di attività che ha come prima “materia prima” la Terra.
Il punto non è tanto l’"appropriazione della natura" quanto piuttosto il modo in cui tale appropriazione avviene ovvero il modo di produzione e ri-produzione dell’oikeios (se vogliamo usare il glossario di Moore) e il (mancato) ricambio organico, il ritorno alla natura, sia pure in forme diverse, di ciò che era stato appropriato.
Dunque, assimilare il discorso dell’appropriazione di “lavoro della natura
umana” a quello dell’appropriazione di “lavoro della natura extra-umana” può essere fuorviante; infatti, mentre dobbiamo auspicare la fine tout court dell’appropriazione privata del frutto del lavoro umano, non possiamo invece
auspicare la fine tout court dell’appropriazione dei prodotti della natura extra-umana perché ogni essere vivente non può non appropriarsene in qualche modo.
In altri termini, mentre dobbiamo auspicare la fine dello sfruttamento del lavoro umano, possiamo auspicare un diverso modo di “attingere” dalla natura, un modo basato sul ripristino del “ricambio organico naturale” di cui parlava Marx.
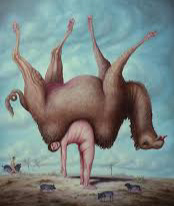

Commenti
Posta un commento