tratto dalla traduzione di E.Vinci al testo "Sustainable Development Goals e Laudato si’: esempi di Post-sviluppo?"; di Wolfgang Sachs.
"Com’eravamo ingenui a proclamare con presunzione la fine dell'era dello sviluppo!"
Nell’autunno del 1988 ci balenò la folle idea di pubblicare un “dizionario dello sviluppo”.
Non un comune manuale, bensì un testo critico che scandagliasse il concetto di sviluppo, parola chiave della Weltpolitik della seconda metà del Ventesimo secolo, in senso foucaultiano.
Secondo Foucault, conoscenza e potere sono inseparabili, tuttavia il potere non si basa necessariamente sulla repressione, ma sulla libertà (seppur indirizzata).
Dunque lo “sviluppo”, nella nostra concezione, era inteso come la materia di cui sono fatti i piani, le previsioni, i sogni.
In breve, una visione del mondo in cui il potere viene esercitato tramite il consenso sociale.
Oltretutto, l’idea di “sviluppo” ha una storia che è tipica di molti altri concetti: ciò che una volta era un’innovazione storica diviene per molto tempo una convenzione e finisce per essere una frustrazione.
Il nostro spiritus rector, Ivan Illich, che sedeva in mezzo a noi, si rese conto che l’idea si adattava perfettamente alla sua archeologia della modernità, che aveva intenzione di scrivere.
Secondo Illich si poteva parlare di “sviluppo” soltanto con uno sguardo retrospettivo.
Se guardiamo indietro, è sorprendente quello che in passato non sapevamo o non immaginavamo nemmeno, ad esempio la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda con le loro implicazioni sul concetto di “sviluppo” utilizzate dal presidente Truman contro il comunismo; il sistema degli stati nazionali ridotto ad un colabrodo dalla globalizzazione dei mercati; un ordine mondiale sempre più policentrico che sta scompaginando la gerarchia delle nazioni e sta minando soprattutto l’egemonia degli Stati Uniti; internet e gli smartphone che hanno creato uno spazio di comunicazione globale e, infine, l’ascesa di Paesi emergenti che ha relegato le tradizionali categorie come “terzo mondo” e “Paesi donatori” nella pattumiera della storia.
Comunque sia, ci opponevamo all’idea di “sviluppo” inteso in termini cronopolitici, geopolitici, e di politiche civili.
Dal punto di vista cronopolitico è come se tutti i popoli sulla faccia della terra avanzassero sullo stesso binario, diretti verso il progresso sociale ed economico, che però non viene mai definitivamente
raggiunto.
Geopoliticamente, invece, i corridori al comando indicano il cammino a tutti gli altri: la molteplicità di popoli nel mondo, un tempo disordinata, si configura in una netta distinzione tra nazioni ricche e nazioni povere.
E infine, dalla prospettiva delle politiche civili, si può definire lo “sviluppo” di una nazione in base al suo grado di rendimento economico, quindi in base al prodotto interno lordo.
Le società che sono appena sfuggite alla colonizzazione devono quindi porsi sotto la custodia dell’economia.
Che ne è stato di questo concetto?
“Sviluppo” è diventata una «parola di plastica», una parola vuota, che conferisce valenza positiva alle intenzioni più contraddittorie.
Tuttavia lo “sviluppo” permane come visione del mondo, poiché è integrato in un intreccio internazionale di istituzioni, dalle Nazioni Unite, passando per i ministeri, fino ad arrivare alle ONG.
Inoltre è possibile ricostruire la notevole metamorfosi di questo concetto fino ai giorni nostri.
Nel 2015 abbiamo assistito a una intensificazione del discorso sullo sviluppo: a giugno è apparsa l’enciclica papale Laudato si’, a settembre gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, abbreviato anche in SDGs) delle Nazioni Unite e, infine, a dicembre, l’accordo sul clima di Parigi.
Questi documenti sono ancora vincolati all’idea di sviluppo?
O, piuttosto, possono essere considerati espressioni del pensiero del post-sviluppo?
La trasformazione del concetto di “sviluppo” negli SDGs
L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha stabilito gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, con l’Agenda 2030, ha stilato un programma che dovrebbe dettare la direzione della Weltpolitik per i prossimi quindici anni.
Esso è il risultato di due processi: da
un lato gli obiettivi di sviluppo del millennio del 2000, dall’altro i documenti della conferenza di Rio+20 del 2012, che riprendeva le fila dell’Agenda 21 del vertice mondiale del 1992.
La redazione degli SDGs ha seguito una lunga trafila, con consultazioni in 88 Paesi, trattative tra gli Stati, una commissione prestigiosa e soprattutto una grande partecipazione della società civile.
In breve, i 17 obiettivi e i 169 sotto-obiettivi stabiliti vanno dal “no alla povertà” passando per “istruzione per tutti”, fino a “energia rinnovabile”.
È un affare complesso, un catalogo di impegni che si avvicina, solenne e visionario, ma non prevede alcun tipo di obbligo, né possibilità di sanzioni.
Non c’è da meravigliarsi se alcuni parlano di un programma che, con le sue richieste vaghe e i suoi scopi pretenziosi, potrebbe invitare i governi all’inazione.
Eppure le dichiarazioni permanenti, anch’esse non vincolanti, sono indispensabili per i governi del mondo.
L’esempio più recente è quello dell’accordo sul clima di Parigi del dicembre 2015, che coniuga un obiettivo considerevole a un impegno piuttosto vago.
O ancora, chi non ricorda i frequenti appelli delle Nazioni Unite per la lotta contro la fame e la protezione dell’ambiente?
Sono soltanto elementi retorici che vengono riproposti già dal congresso mondiale sul cibo di Washington del 1963 o dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano del 1972 a Stoccolma.
Anche i governi più volenterosi sono in una situazione spiacevole.
Da una parte devono arrendersi alla pressione dei problemi oggettivi e alla spinta della società civile; dall’altra sono vincolati ai mercati capitalistici come anche ai desideri di consumo della loro
società.
Di conseguenza c’è un necessario potenziale simulativo insito nelle dichiarazioni delle Nazioni Unite.
Si comportano come se… mentre già traspare la logica di mercato.
Si tratta più di una notevole dose di auto-inganno che di errore.
D’altra parte il palcoscenico delle Nazioni Unite è perfetto per proclamare nobili obiettivi e poi adoperare la Realpolitik nella quotidianità.
Così la discrepanza tra retorica internazionale e misure nazionali è diventata una caratteristica strutturale della politica contemporanea.
Come si può interpretare la dichiarazione dei governi “Ci impegniamo a lavorare instancabilmente per una totale attuazione dell’Agenda 2030” se non come un esercizio di simulazione, dato che sono gli stessi governi a favorire l’estrazione di carbone, il land grabbing o l’industria finanziaria?
Sopravvivenza anziché progresso
È ormai lontano il tempo in cui lo sviluppo era ancora una promessa.
Allora si parlava di nazioni “giovani”, “ambiziose” sulla via del progresso.
In effetti la crono-politica, la geopolitica e
le politiche civili sullo sviluppo hanno generato una monumentale promessa storica, la promessa che alla fine tutte le società sarebbero state in grado di colmare il divario tra ricchi e poveri e di cogliere i frutti della civiltà industriale.
Il discorso sullo sviluppo ha dovuto incassare due colpi da cui non si è ancora risollevato: la persistenza della povertà e la finitezza della natura.
Gli aiuti a favore dello sviluppo si sono
concentrati sulla lotta alla povertà, tuttavia la sua riproduzione costante, anche dopo la scadenza del termine previsto perché venissero raggiunti gli obiettivi del millennio, rimane allarmante.
Sicuramente il numero delle persone in condizione di povertà assoluta è calato drasticamente nei Paesi emergenti, ma nei Paesi più poveri è rimasto invariato.
Inoltre, la politica per la riduzione della povertà paga il prezzo di un’enorme disuguaglianza e dei danni ambientali.
Secondo colpo: il surriscaldamento globale, la perdita della biodiversità, l’avvelenamento di mari e terre, tutto ciò ha tolto fondamento alla convinzione che i Paesi sviluppati fossero all’apice dell’evoluzione.
Al contrario, il progresso si è rivelato in larga parte come regresso, perché l’economia del nord del mondo non può far altro che sfruttare la natura.
Le analisi, da Limits to Growth del 1972 a Planetary Boundaries del 2009, parlano
chiaro: lo sviluppo inteso come crescita conduce all’inospitalità del pianeta Terra per il genere umano (e non solo).
Il bene comune contro la tecnocrazia
In una democrazia pluralista il bene comune è sottoposto a un processo di continua ricerca: finché si sostiene che la società non debba essere una marionetta nelle mani del potere e dell’interesse del singolo, il concetto di bene comune è indispensabile.
Di conseguenza tale concetto ha dominato la filosofia politica, nelle sue varie sfaccettature, sin dall’antichità e riaffiora con forza nell’enciclica Laudato sì.
Dal punto di vista delle politiche civili, l’enciclica rivendica il fiorire in tutte le società del bene comune, inteso non solo in senso tradizionale, come bene politico e sociale, ma anche come bene ecologico.
Se volessimo riassumere questi due documenti del 2015, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, potremmo dire: l’entusiasmo per lo sviluppo che ha caratterizzato il Ventesimo secolo è scomparso, adesso si cerca di far fronte al tramonto della modernità espansiva.
Il motto del secolo scorso era “nell’Occidente come in Terra”, che adesso si è rivelato una minaccia.
Il mondo si trova sull’orlo del precipizio: la biosfera è distrutta e, come se non bastasse, il divario tra ricchi e poveri, sotto diversi punti di vista, è aumentato.
Dunque, entrambi i documenti concordano sul fatto che il modello economico globale è ormai da considerare come un ferro vecchio, ma ci sono anche grandi differenze.
Mentre l’Agenda 2030 vuole correggere in modo significativo il modello economico mondiale, l’enciclica sostiene che l’egemonia economica debba essere respinta a vantaggio di una maggiore responsabilità etica a tutti i livelli.
L’Agenda 2030 punta su un’economia verde con sfumature socialdemocratiche, mentre l’enciclica immagina un’età post-capitalistica, basata su un cambio di mentalità eco-solidale.
La modernità espansiva è finita.
Più questo punto di vista si diffonde nel mondo, più si attenua il discorso sullo sviluppo e con esso anche quello sul post-sviluppo.
In tal modo i problemi delle società non vengono più concepiti come problemi legati allo sviluppo e si modificano le strutture mentali.
Al momento è popolare pensare in termini campanilisti; questo tipo di pensiero si nutre di un misto tra nazionalismo, xenofobia e autoritarismo, condito da una buona dose di sciovinismo del benessere.
Inoltre, genera spesso il desiderio di un “uomo forte” con cui la parte emarginata della popolazione può identificarsi.
Dall’altra parte la narrativa del globalismo giura fedeltà alla crescita economica con la conseguente promessa, nonostante tutto, di maggiore benessere.
L’Agenda 2030 segue in larga parte questo tipo di pensiero.
L’etica eco-solidale, invece, si oppone
alla mentalità campanilista e sostiene un cambiamento culturale, sia locale che globale, consolidato da forme di economia cooperativa e da una politica orientata al bene comune.
Nell’interesse dell’equità, bisogna porre fine allo stile di vita imperialista della classe media transnazionale, mentre lo “sviluppo”, come la monarchia o il feudalesimo, scivolerà nella polvere della storia.
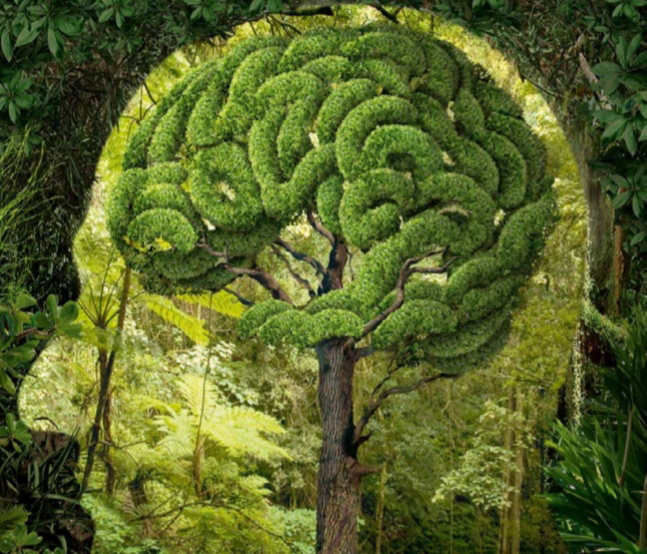

Commenti
Posta un commento