La produzione del territorio e la territorializzazione del potere cinese nell’Amazzonia Ecuadoriana.
tratto da "Il serpente e il drago. Riflessioni sulla territorializzazione degli investimenti cinesi nell’Amazzonia ecuadoriana"; di Carolina Viola Reyes.
https://www.academia.edu/62146803
Il XXI secolo è stato lo scenario del consolidamento della Cina nel sistema mondo, nonché della riconfigurazione geopolitica del capitalismo globale.
L’America Latina concentra importanti riserve di petrolio, gas e altri minerali, nonché di acqua potabile e terre idonee per la produzione di cibo.
Ecco perché la regione è un hot-spot nella geopolitica globale delle risorse naturali.
Tra il 2005 e il 2021 l’Ecuador, ad esempio, ha ricevuto dalle policy banks cinesi una cifra pari a circa 18,4 miliardi di dollari, inferiore soltanto a quelle ricevuti da Venezuela e Brasile.
Questi investimenti includono spesso accordi di vendita anticipata di petrolio.
I progetti sono realizzati direttamente dalle imprese cinesi, con diversi gradi di esclusività, in funzione degli accordi sottoscritti.
Nella maggior parte dei casi, si tratta di contratti «chiavi in mano»: cioè uno schema di appalto pubblico dove lo stato si limita a ricevere l’opera conclusa nei tempi previsti, lasciando all’impresa il controllo totale sul processo di costruzione.
Questo modello di contrattazione è presentato come necessario in funzione della complessità dei lavori d’ingegneria ma finisce per ridurre drasticamente la trasparenza e quindi le possibilità di monitoraggio da parte della società civile.
L’impresa è lasciata libera di stabilire gli standard di assunzione della mano d’opera così come le forme e i luoghi di approvvigionamento dei beni e servizi necessari ai lavori.
L'appalto è concesso senza la realizzazione di studi approfonditi che permettano di valutare i rischi di opere di vasta portata.
L’esecuzione delle opere è costellata da conflitti sindacali: maltrattamenti e abusi sui lavoratori, pessime condizioni di alimentazione e sicurezza, tutti oggetto di molteplici denunce.
La ricerca con gli operai in Ecuador ha permesso di indicare la presenza di operai cinesi in regime di commutazione di pena, cioè di un regime di semi-schiavitù del tutto incongruente con la legislazione ecuadoriana.
Questi lavoratori rimanevano costretti in una mobilità estremamente ridotta, erano rinchiusi nel cantiere e i loro salari erano versati direttamente ai familiari in Cina.
Nel dicembre del 2014 un incidente sul lavoro era costato la vita di 13 operai in condizioni mai chiarite; mentre si denunciavano sovraprezzi e utilizzazione di materiali di bassa qualità.
I problemi interni ai cantieri sono solo una minima parte di quelli che si determinano sui territori e sulle dinamiche della produzione quotidiana dello spazio: la trasformazione delle logiche produttive, l’incremento del divario di genere rispetto alle opportunità di lavoro e l’aumento della violenza.
I grandi lavori cinesi determinano infatti una maschilizzazione del territorio le cui conseguenze sono subìte da donne e bambine; allo stesso modo, l’incremento del consumo di alcool e la prostituzione contribuiscono ad elevare la violenza intra-familiare.
La mancanza d’informazione e di studi indipendenti sugli impatti mette in grave rischio la vita dei popoli indigeni e contadini.
Il rapporto sino-latino-americano ha portato ingenti quantità di risorse ai governi sviluppisti di Argentina, Brasile, Ecuador, Venezuela e Bolivia in un periodo di difficile accesso al finanziamento internazionale.
La Cina è diventata così un socio fondamentale nei piani di costruzione di infrastrutture statali in questi paesi ma, lungi dall’essere orizzontale, questo rapporto è attraversato da molteplici asimmetrie.
Estrattivismo nel secolo XXI: l’America Latina e le sue periferie estreme
Le trasformazioni accelerate nella geopolitica del capitalismo che accompagnano l’inizio del secolo XXI si traducono nell'esasperazione della competizione per il controllo delle risorse naturali su scala planetaria.
Questa corsa si sta amplificando nel contesto della crescente competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti.
Una delle conseguenze di questa dinamica riguarda le strategie complesse di gestione delle popolazioni nelle cosiddette extreme peripheries.
La definizione di periferie estreme evoca i territori destinati all’estrazione di risorse naturali ai margini degli stati periferici del sistema mondo.
Questi territori si configurano come periferie economiche, sociali, politiche e spaziali; tra tutte, l’Amazzonia rappresenta l’archetipo di questa configurazione socio-spaziale.
L’aggettivo "estremo" sottolinea le molteplici dimensioni nelle quali si territorializza la sua condizione periferica e marginale.
L’approfondimento, l'accelerazione e la trasformazione delle dinamiche di estrazione delle risorse naturali nei territori della periferia estrema è la caratteristica del nuovo secolo.
Si possono sintetizzare queste mutazioni dell’estrattivismo secondo quattro principali dimensioni:
1) l’esaurimento dei beni naturali non rinnovabili, che rende visibile l’insostenibilità del modello di produzione e consumo attuale;
2) il progresso tecnologico, che permettendo di aumentare le capacità d’estrazione ha spinto e spinge la frontiera estrattiva fino ai limiti;
3) la riduzione dei beni necessari alla vita a materie prime (commodities) dei processi estrattivi, che ha portato al superamento del tasso di recupero ecologico dei beni naturali rinnovabili;
4) la trasformazione in commodities di tutti questi beni, che diventano esportabili, negoziabili e oggetto di speculazione nei mercati finanziari globali.
La nuova fase dell’estrattivismo nelle periferie estreme si caratterizza dunque per le forme estreme di distruzione e violenza, normalizzate nell’ordine discorsivo che riproduce il potere estrattivista.
L’elemento più rilevante del progetto estrattivista del secolo XXI è il suo carattere olistico e totale, intimamente vincolato alla riconfigurazione della geopolitica del capitalismo su scala planetaria.
Il flusso dei capitali cinesi verso l’America Latina è aumentato velocemente lungo tutto il primo decennio del secolo XXI.
Questi nuovi capitali hanno dato un respiro ai governi latinoamericani che mettevano in discussione l’imposizione delle ricette di aggiustamento del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale.
Oltre ai terribili effetti sociali, le politiche economiche implementate dalle istituzioni di Bretton Woods nell’ambito del Consenso di Washington hanno paradossalmente creato condizioni favorevoli per l’arrivo di nuovi attori in generale e della Cina in particolare.
Allo stesso tempo la Cina ha proposto schemi di collaborazione orizzontale ai paesi in via di sviluppo, quali il rispetto della sovranità nazionale e l’assenza di particolari condizioni politiche ed economiche.
I piani di investimento in infrastrutture dei governi neosviluppisti di Ecuador, Brasile, Argentina, Venezuela e Bolivia si sono così concentrati sul miglioramento delle condizioni di competitività sistemica per l’esportazione di commodities e su un investimento marginale nell’industria.
Questi investimenti da un lato sono complementari al fabbisogno di risorse naturali del gigante asiatico, dall’altro tentano di cercare nuovi sbocchi.
L’espansione cinese nella regione non si è limitata ai governi cosiddetti progressisti, ma ha coinvolto l’intero subcontinente, Colombia e Perù compresi.
Diventano dunque evidenti le dimensioni del paradosso nel quale la regione è caduta: la diversificazione delle fonti di finanziamento (dai flussi occidentali gestiti dalle istituzioni di Bretton Woods ai flussi asiatici) non ha determinato nessuna diversificazione economica, ma solo un ampliamento del loro profilo da primo esportatore e quindi un aumento dei loro squilibri atavici.
La diversificazione delle relazioni commerciali e politiche di ognuno dei paesi latinoamericani, e nell’ambito del loro insieme come blocco, ha permesso di agire con livelli di autonomia e indipendenza dalla superpotenza statunitense senza precedenti.
Perciò la congiuntura politica ed economica ha consentito il consolidamento di un'agenda sino-latinoamericana, fondata da un lato sulla necessità permanente di risorse economiche dei governi latinoamericani e, dall’altra parte, sull’interesse cinese per le risorse naturali abbondanti dell’America Latina.
La sete di materie prime
L’America Latina dispone abbondantemente di minerali, petrolio, gas naturale e di un grande potenziale per la produzione di energia idroelettrica e di energia rinnovabile non convenzionale.
Le sue terre, dalla pampa argentina all’America Centrale, passando per l’Amazzonia brasiliana, producono volumi giganteschi di cereali (soia), frutta tropicale e carne per l’esportazione.
Negli ultimi dieci anni, sono incrementate le esportazioni di cibo di origine agricola e animale in Cina; fin dall’anno 2016 il Brasile è in testa in questo ranking globale, mentre l’Argentina occupa il settimo posto.
Il Sudamerica vanta la concentrazione più alta di queste risorse e non è dunque un caso che la regione sia diventata il punto focale per gli acquisti e gli investimenti cinesi: il petrolio sudamericano rappresenta il 19,5% del totale globale, distribuito in maniera variabile tra Venezuela, Brasile, Colombia ed Ecuador; anche il gas è abbondante, con giacimenti in Argentina, Bolivia, Brasile, Perù e Venezuela.
Per quel che riguarda gli idrocarburi non convenzionali, una ricerca della Us Energy Information Administration (Eia) pubblicata nel 2011 stimava l’esistenza di risorse importanti in Argentina, Uruguay, Colombia e Brasile.
Oggigiorno, l’America Latina è la seconda fonte, in ordine di rilevanza, delle importazioni cinesi di petrolio, con una partecipazione del 13,5% del totale.
Questo scenario si riproduce per i giacimenti e le miniere di ferro e più in generale per le risorse minerarie.
Il Brasile ha esportato nel 2019 quasi 24 milioni di dollari in minerali e metalli verso la Cina – è la seconda fonte di queste risorse, preceduta solo dall’Australia e seguita da Cile e Perù.
Tra il 2005 e il 2020, la Cina ha concesso prestiti all’America Latina e ai Paesi caraibici per circa 135 miliardi di dollari.
I principali destinatari sono stati – in ordine di rilevanza – Brasile, Venezuela, Argentina ed Ecuador.
Si tratta un volume totale di finanziamento maggiore dei prestiti combinati della Banca Mondiale (Bm) e della Banca Interamericana di Sviluppo (Bid) nello stesso periodo.
Questi investimenti sono stati principalmente indirizzati a progetti per l’infrastruttura pubblica, la connettività e per l’estrazione di vecchie e nuove commodities che impattano spesso sui territori dei popoli amazzonici.
Risulta evidente quanto la geopolitica delle risorse naturali sia il motore delle crescenti relazioni politiche ed economiche tra Cina e America Latina in questo XXI secolo.
Considerazioni finali
L’estrattivismo del XXI secolo si sviluppa nel contesto della diversificazione dei poli di produzione capitalista globali, conseguenza dell’ascesa della Cina e del Sud Est Asiatico, così come dello spostamento degli assi centrali dell’economia globale dall’Atlantico al Pacifico.
Questa situazione si traduce nell’aumento delle pressioni per l’allargamento della frontiera estrattiva verso territori rimasti finora esclusi della carta geopolitica della corsa per le risorse naturali.
Il motivo di questa esclusione non è stata certamente la volontà di conservazione ecologica, bensì gli alti costi economici, sociali e ambientali impliciti in questi progetti, così come il potenziale di rifiuto e resistenza da parte della società civile.
Molte di queste iniziative sono rimaste nel cassetto per anni prima di diventare progetti prioritari nell’agenda pubblica.
Ci sono tre fattori rilevanti per capire questa propensione al rischio assunta dai governi latinoamericani nel XXI secolo:
1) l’arrivo dei capitali cinesi disposti ad entrare nei territori nonostante alti livelli di conflittualità;
2) le politiche sviluppiste dei «progressismi» latinoamericani;
3) gli avanzamenti tecnologici e l’alto prezzo delle materie prime.
Rispetto ai capitali cinesi, la dinamica si è caratterizzata per la presenza delle Soe (State Owned Enterprises) sostenute dalla banca pubblica cinese e dalla sua diplomazia.
I progetti vengono accompagnati da risorse economiche sotto forma di prestiti poi realizzati direttamente dalle compagnie cinesi.
Le Soe privilegiano gli accordi stato a stato, garantendo così la protezione degli investimenti cinesi attraverso i corpi repressivi degli stati latinoamericani.
Questa condizione è divenuta necessaria considerando le forti resistenze nei confronti di questi progetti; lo Stato, insieme alle Soe cinesi, impone stati di eccezione, facilitando la spoliazione dei territori e dei popoli.
Emerge così un nuovo schema di governamentalità estrattivista che presuppone forme radicali di controllo e amministrazione delle popolazioni.
I progressismi latinoamericani hanno colto un’opportunità nella diversificazione dei rapporti politici ed economici con la Cina, la quale si presentava come un socio ineguagliabile nel processo di recupero dell’infrastruttura statale.
Le fiorenti relazioni stato-stato e il carattere autarchico dei progressismi latinoamericani sono stati una combinazione vincente per l’espansione dell’estrattivismo al di sopra delle proteste e delle resistenze.
Infine, questo scenario politico favorevole si nutre anche delle scoperte tecnologiche e del ciclo espansivo nei prezzi delle commodities, che hanno fatto diventare redditizi progetti rischiosi e dispendiosi, prima neppure presi in considerazione.
È così che l’espansione della frontiera estrattiva mira, golosa, all’Amazzonia, perseguendo la colonizzazione e la spoliazione dei territori e dei popoli tutt’oggi sotto il mirino della sete di risorse dei capitali e dei poteri globali.

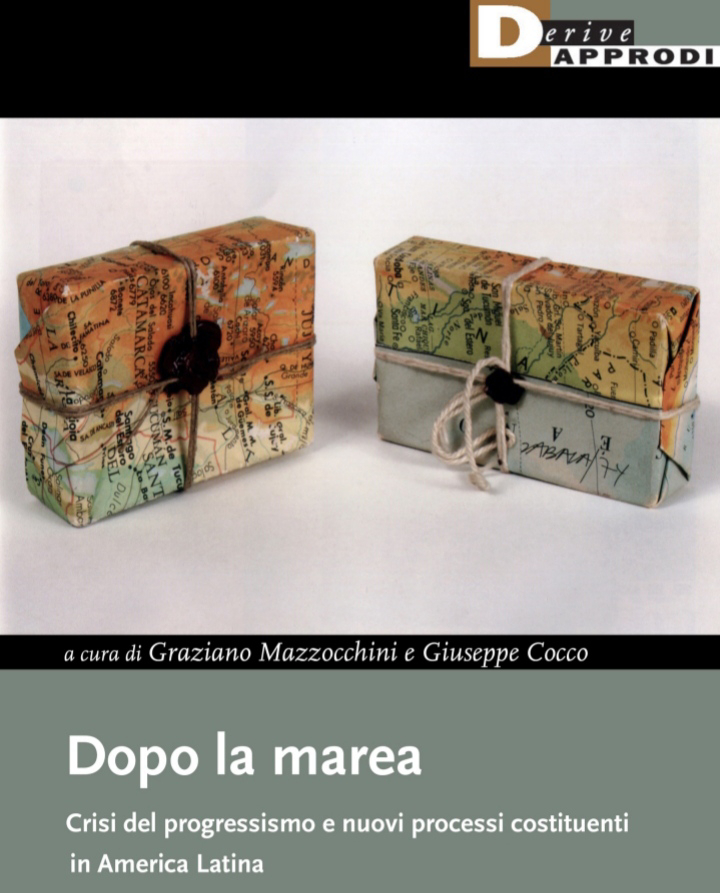
Commenti
Posta un commento